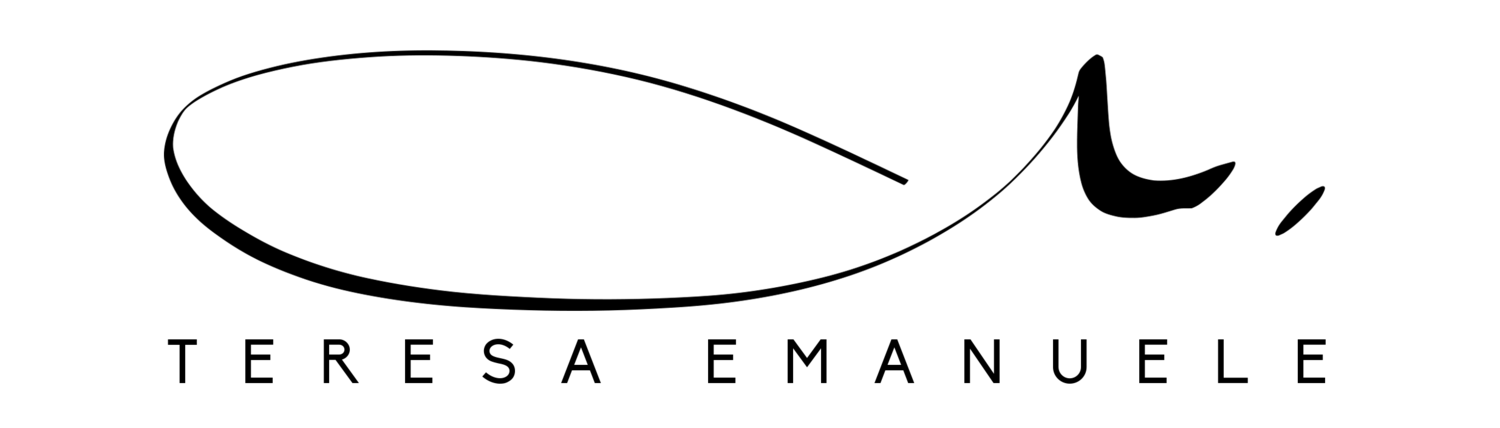A cura di Luca Beatrice
In quell’immenso contenitore di nozioni che è Wikipedia, il termine “Ecfrasi” (dal greco “Ekphrasis”, utilizzeremo entrambe le diciture) viene innanzitutto definito come “la descrizione verbale di un’opera visiva”. Nello scegliere quale titolo della mostra questa parola così desueta e arcaica (oggi, si sa, i giovani artisti preferiscono utilizzare la lingua inglese della globalizzazione piuttosto che addentrarsi nella riscoperta della propria matrice classica) Teresa Emanuele passa la parola alla critica, ponendoci di fronte a una serie di immagini fotografiche di rara bellezza, quasi interamente in bianco e nero (solo alcune presentano lievi tocchi di colore che mi rimandano a cartoline della mia infanzia). Rappresentano questi scatti – di cui non importa conoscere il dove, il come e il quando – le sue recenti intuizioni sulla natura e il rapporto che un artista appunto può oggi intrattenere con essa. Correndo in una strada molto diversa da quella normalmente battuta – sono sempre più frequenti fotografie di periferie, case popolari e distruzioni ed è invece ben più raro che l’occhio indiscreto della camera si posi su un particolare che regali bellezza da sé – il suo lavoro potrebbe essere “accusato” di eccessiva letterarietà. Ed è proprio questo presunto limite che si rivela invece il punto di forza, la sua assoluta originalità teorica, soprattutto se paragonato allo stile diffuso di una fotografia scialba e poco curata, che non rispetta la sintassi né le regole linguistiche implicite al mezzo.
Alla ricerca di una suggestione giustappunto “ecfrasica”, per avvicinarmi correttamente al lavoro di Teresa Emanuele mi soccorre un paragrafo incluso nell’ottimo saggio di Massimo Fusillo, Feticci (Il Mulino, 2012) che studia le relazioni e i nessi tra l’investimento su oggetti di particolare valore simbolico e la finzione creativa a tutto tondo, in letteratura, nel cinema e nelle arti visive. Se l’opera deve essere capace, in primis, di emanare seduzione, decisivo sarà il modo in cui la scrittura sceglie di raccontarla, soffermandosi ad esempio sul particolare a margine invece che sul nodo che ne esprime il senso. Si può praticare la critica scegliendo un movimento centripeto oppure uno centrifugo, e personalmente preferisco questo secondo. Precisa infatti Fusillo, “l’attenzione descrittiva verso il mondo degli oggetti è stata a lungo relegata ai margini” perché ritenuta eccessivamente verbosa e digressiva. Eppure, continua, “l’interazione tra parola e immagine, tempo e spazio, narrazione e descrizione ha una lunga storia alle spalle, a partire dall’Iliade e dall’ekphrasis dello scudo di Achille in cui il dato visivo viene trasfigurato liberamente in racconto”. Per estensione, a questa figura letteraria appartengono tutte quelle digressioni e quelle pause dalla vicenda principale, frequenti nel romanzo classico (da Don Chisciotte ai Promessi sposi, il cui intreccio potrebbe sciogliersi in poche pagine se gli autori non avessero escogitato il meccanismo del ritardo con il quale esercitare con perizia la funzione “ecfrasica”). In realtà anche quando “l’ekphrasis si focalizza su un unico momento statico, sospendendo la temporalità, non esclude mai una tensione narrativa” e quindi “descrizione e racconto non si possono mai in fondo distinguere nettamente, sulla base di una presunta essenza dei singoli linguaggi”.
Allontanandoci gradatamente dalla classicità per affrontare l’epoca moderna, si rivela in alcuni tipi di scrittura quella propensione all’ecfrasi, ad esempio in autori come “Diderot, Baudelaire, Ruskin, Proust, Woolf, Rilke che evitano l’analiticità dettagliata e preferiscono una critica creativa ed evocativa, basata sull’idea di percezione come attività infinita”. Per Fusillo è importante evitare di far coincidere il concetto di ekphrasis con quello di critica d’arte tout-court, e a tal proposito cita un testo di James Heffernan, Museum of Words (2004) che ci avverte che “l’ekphrasis è la rappresentazione verbale di una rappresentazione visiva e non può confondersi con il pittorialismo, cioè la presenza in letteratura di effetti visivi, o l’iconicità, l’uso letterario di tecniche grafiche che richiamano per somiglianza il contenuto dell’opera”.
Ci stiamo rapidamente avvicinando al senso poetico di Teresa Emanuele, il cui lavoro è in effetti basato sull’esercizio del particolare isolato da un meccanismo narrativo, nonostante a lei piaccia organizzare le sue fotografie per serie: “Ecfrasi al sole, Ecfrasi dell’acqua, Ecfrasi solitaria ecc…”. Il nostro tempo, fin dall’epoca del Bauhaus, sviluppa il concetto, invero eccessivamente schematico, per cui l’ornamento è un delitto (Adolf Loos) e che, comunque, “less is more” (Mies van der Rohe), ereditando in tal senso la convenzione dall’epoca classica secondo la quale la descrizione è un orpello. Eppure sono proprio le pause narrative, il proliferare di digressioni che danno luogo alla pienezza narrativa, “il piacere dell’affabulazione infinita che non a caso affascinava Goethe.” Nella critica, letteraria soprattutto ma anche d’arte, è stata prevalente per lungo tempo la “posizione di Lukacs, marxista, che contrappone il realismo di Balzac, in cui i dettagli descrittivi sono sempre funzionali al racconto e ai personaggi, all’impressionismo di Flaubert e Zola, in cui i particolari diventano natura morta autonoma, senza integrarsi in un contesto unitario e organico”. A ciò andrebbe aggiunta la pittura impressionista, non a caso ritenuta primo avamposto dell’avanguardia novecentesca.
Racconta l’artista di una vera e propria ossessione per gli alberi, “gli unici esseri che continuano a crescere durante la loro intera, secolare esistenza, sempre verso l'alto, verso la luce, verso il sole, in maestosa staticità e silenziosa saggezza”. Osservare le gocce di rugiada su una foglia, la perfezione simmetrica in un piccolo ramo, l’infilata di alberi organizzata come un esercito a riposo significa riflettere su quegli oggetti (che Fusillo individua come feticci) intimamente legati a un sapere antigerarchico, “alla valorizzazione del dettaglio, del quotidiano, delle cose materiali in cui trova uno spazio sempre maggiore la descrizione e l’intera dinamica della visualità come il romanzo moderno dopo Flaubert”. Si tratta di oggetti insignificanti nella loro quotidianità e la loro precipua funzione sta nel dirci: “noi siamo la realtà” (la citazione in seconda battuta è di Roland Barthes).
Lo sguardo dove si posa la macchina fotografica di Teresa Emanuele appartiene al mondo della natura. Non vorremmo scomodare l’aggettivo “naturalista” applicato alla pittura di metà novecento, dopo la crisi dell’Informale a fronte della necessità di cercare un ancoraggio più profondo con la realtà senza scivolare nell’eccesso di realismo. Potremmo forse riferirci alla classica fotografia di paesaggio in bianco e nero, con uno spettro che va da Mario Giacomelli al regista iraniano Abbas Kiarostami, da Ansel Adams a Olafur Eliasson (i suoi sono solo intermezzi tra un’installazione e un’altra, ma che intensità): ma non esattamente di questo si tratta. Teresa Emanuele è artista contemporanea, abituata a muoversi e confrontarsi sui temi “caldi” del nostro tempo (dalle visioni metropolitane newyorkesi all’attività umanitaria in Africa). E’ artista viaggiatrice e nomade ma niente affatto tentata dal reportage; piuttosto, si interroga sul ruolo culturale della natura nel terzo millennio e su come rappresentare uno stato così critico che negli ultimi tempi ha rimesso in moto l’elemento perturbante caro alla filosofia dell’Ottocento. Secondo i poeti e i pittori romantici, che mutuavano la suggestione dalla kantiana Critica del giudizio, di fronte ad un paesaggio particolarmente bello e seducente era impossibile non coglierne quell’aspetto sinistro e minaccioso; l’alta montagna, il cielo di notte, il mare increspato che dovevano mettere in subbuglio l’animo di Jacopo Ortis, del giovane Werther, del pittore Caspar Friedrich. Ai romantici piaceva farsi coinvolgere sul piano del sentimento emotivo interiore, oggi invece la natura minaccia perché è minacciata dall’irresponsabilità e dalla follia umana.
Teresa Emanuele non si occupa di questo aspetto “ambientalista”, che investe una riflessione comunque più responsabile sugli effetti di devastazione dell’equilibrio naturale, né evoca una sorta di paradiso perduto, di eden arcadico. Semplicemente sceglie il particolare e la digressione, le ombre invece della luce, tentando di dar movimento a queste sue superfici così ricche di vibrazioni. E le piace raccontare tutto questo con semplicità andando diretta al centro dell’emozione: “mi affascina la sfida al mezzo statico per eccellenza. Ho voglia di intrappolare ombre mentre scrivo con la luce. L'ombra come specchio di tutto l'intorno, ma privo di identità. La mia ombra sono io ma senza volto. E l'ombra di un albero disegna le ore del giorno senza distinzione di stagione. Ho catturato il mio albero, l'ho preso. Ben due volte. La prima in quella frazione di secondo in cui si è fermato per me. La seconda oggi, nella mia scatola. Ho catturato la sua identità e la sua ombra senza volto”.